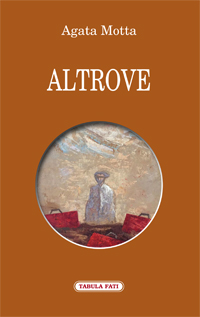La notte turbinosa di Jack London. ‘Figlio del lupo’ di Romana Petri, ed. Mondadori
@ Agata Motta (31-03-2020)
Letteratura. Saggistica breve.

Alaska
Tra le immagini dei cercatori d’oro del Klondike, in compagnia dei tanti sventurati e per lo più illusi avventurieri e del mitico e più fortunato Paperon de’ Paperoni, si può aggiungere a pieno titolo quella del giovane Jack London che tornò da quell’impresa con le pive nel sacco e un filone inesauribile di idee in testa.
Figlio del lupo, ultimo romanzo di Romana Petri edito da Mondadori, racconta la mirabolante vita di uno degli scrittori più prolifici e celebri che si mossero a cavallo di due secoli pregni di eccellente letteratura, ma sarebbe ingeneroso e addirittura fuorviante sostenere che il suo libro si limiti a questo. La Petri consegna un altro testo irrinunciabile per lo scavo profondo nell’intimità e nel percorso umano e letterario di uno scrittore che le è per certi versi affine, per quella massa incandescente di rappresentazioni che attingono a mondi lontani facendone avvertire la presenza attraverso tutti i sensi, come se fossero appena dietro l’angolo, per certe frasi di autentica bellezza che restano impresse nel cuore come se appartenessero al lettore e non a chi le ha concepite.
Le iniziali pagine in corsivo, che si distendono con brevi intervalli irregolari per una buona metà del testo, bloccano il protagonista, ospite di un caro amico, nel momento dello snodo che lo ha consacrato al successo e della rottura – sotto certi aspetti vile – con la prima moglie Bessie che gli ha dato due figlie femmine. Sarà una notte di turbinosi ricordi avviata dalla rievocazione delle cascate del Niagara, luogo di perfetta identificazione e metafora possente di una vena inarrestabile di pensiero e di azione che indicherà la rotta ad un marinaio/scrittore sedotto da mille altre vocazioni, tutte seguite con ieratica solennità e, spesso, concluse in catastrofiche sconfitte.

Jack London
London appare inizialmente come lo scrittore in grado di “trasformare buona parte del piombo che aveva nella testa in oro scintillante”, l’artista che voleva consegnare ai posteri “una letteratura con poco profumo ma molto odore di vita”, guardando a Kipling come alla stella cometa. Poco alla volta, si trasformerà in uno scrittore compulsivo alla perenne ricerca di nuovi traguardi, in una macchina per produrre denaro, quel denaro essenziale all’edificazione dei suoi straordinari progetti: una nave con la quale effettuare il giro del mondo in sette anni, una casa/castello, la Tana del Lupo, sulla più bella e progredita tenuta della California nella quale realizzare la propria utopia socialista. Denaro che entra a palate e fuoriesce a fiumi, perché la generosità (spesso ottusa e fuori misura) è la virtù o il vizio che lo accompagna sin da bambino, quando consegnava alla madre Flora – una spiritista in perpetuo colloquio con i defunti baciata in fronte da idee disastrose – tutto il guadagno raggranellato nei lavori più faticosi e disparati.
La consueta prosa della Petri, tersa, distesa, ricercata sotto il profilo lessicale, è percorsa dal fremito delle agili capriole di un periodare fluido e corposo che si insinua nell’intreccio, continuamente franto da analessi e prolessi che rendono il tempo ondivago e sovrapponibile, per sorreggerlo, restituendo stabilità a pagine che inseguono la velocità del pensiero.

La staticità non appartiene allo scrittore protagonista, votato ad un vorace assalto alla vita e a tutte le sue manifestazioni, quindi non possono esserci ristagni ed esitazioni nel processo affabulatorio di un’autrice che si immedesima nei personaggi fino a farsene possedere completamente, fino a coincidere con essi. E il meccanismo giunge alla perfezione quando la Petri incontra i bisogni, le pulsioni, i desideri, le angosce, i sogni di London, perché sono entrambi scrittori di sulfurea materia, ciò che scrivono sembra appena eruttato da vulcani impetuosi e possiede proprietà taumaturgiche ambivalenti: curano l’autore, che si libera di porzioni dilaganti di creatività – spesso somigliante ad un malessere che incide senza misericordia l’animo di chi la possiede – e curano il lettore, che attraverso quella stessa creatività – potenziale confronto o brusco scossone – si nutre e si fortifica. Non è un caso se l’aggettivo “sulfureo” torna spesso per definire lo stato d’animo e la prosa di London, non può che apparire tale chi ha consumato la propria breve vita a tappe forzate, incendiandola di fallimentari furori, dissipandola in eccessi autodistruttivi e accecandola con il bagliore di sogni grandiosi che la sorte – madre affettuosa, esigente e ingrata come quella biologica – non gli consentì di realizzare, neanche nelle richieste più umili, come la nascita di un figlio maschio destinato ad accompagnarlo in impetuose cavalcate solo nella fertile immaginazione. Una beffa del destino per chi di padri ne ebbe due – quello che lo rinnegò ancor prima di nascere e quello che lo amò pacatamente dandogli il proprio cognome – e avrebbe fatto qualunque cosa per dimostrare di poter essere lui stesso un buon padre. E per farlo in maniera piena e completa era necessario che venisse al mondo un altro piccolo Jack, una prosecuzione di se stesso, un duplicato o comunque un essere della sua stessa carne e del suo stesso sangue cui lasciare in dotazione il proprio sapere, le proprie scoperte, il proprio animo assetato di infinito. Un desiderio tanto disperato da portarlo infine a concepire l’adozione di tutti i bambini che sarebbero cresciuti nella sua tenuta, in un continuo ed inesauribile ricambio.
Se non si conosce la biografia di London, la scoperta che morì a quarant’anni folgora come un’assurdità inaudita. Possibile? Tutta quella vita e tutti quegli scritti in soli quarant’anni? Tante vite in una soltanto, in un procedimento in fondo simile a quello messo in atto dalla seconda moglie Charmian che invece, per amore, riusciva ad essere tante donne in una, fino alla metamorfosi finale, suggeritagli dall’uomo venerato ormai in vistoso stato di degrado fisico, nella saggia donna “che lascia libero il marito di rovinarsi con le sue mani”.
Non si dubita del fatto che la Petri abbia attinto a fonti primarie per la ricostruzione puntuale di una vita sulla quale è stato possibile sbizzarrirsi per avallare l’ipotesi dello scrittore tutto genio e sregolatezza, alcolizzato, scialacquatore e probabile suicida, o quella dell’uomo complesso, sofferente e roso dalle tante contraddizioni, ma non è stata l’etichetta da apporre sul personaggio ciò che l’autrice ha cercato nel suo lavoro. Scovare corrispondenze, menzogne letterarie o verità assolute è del tutto irrilevante, perché la Petri racconta l’avvincente storia di un uomo e della lotta per l’affermazione delle sue idee e dei suoi sogni, di un uomo sentimentalmente combattuto tra un’idea d’amore romantica (la fragile e borghesissima Mabel) o astratta (la sofisticata, bellissima e troppo intellettuale Anna) e una concezione del matrimonio basata sulla “ragionevolezza” e la concretezza, il matrimonio visto come barra equilibratrice per le tante derive dello spirito.

Romana Petri
Muse, compagne, amiche, amanti, le donne furono sempre e comunque fonte di confronto e di ispirazione, motivo di lancinanti dolori e magiche ebbrezze, prime tra tutte la bizzarra madre e la materna sorella e poi la poesia struggente delle donne mai realmente avute e la prosa rassicurante delle mogli mai profondamente amate.
E allora Jack London potrebbe essere qualsiasi altro uomo e il suo fascino resterebbe intatto, perché Figlio del lupo scavalca il genere biografico per consegnarsi come romanzo puro, con un procedimento simile a quello adottato ne Le serenate del ciclone, in cui la storia del proprio padre, il cantante lirico e attore Mario Petri, è appunto la storia di un uomo e delle sue fragili e precarie conquiste, dei suoi affetti, della sua vitalità prorompente, delle sue disillusioni.
Di Jack London, l’uomo con il vento in testa e il fuoco nelle vene, le immagini che non si sradicheranno dalla memoria sono quelle che lo ritraggono con le prime crepe addosso, con quell’amarezza profonda per i pochi “atti mancati” non compensati dalla miriade di atti compiuti, con quell’insopprimibile tensione di morte già presente negli anni in cui la brama di vita lo divorava interiormente.
“Eppure, nonostante tutto l’amore che Jack metteva nelle cose, le cose gli si spegnevano tra le braccia.”
Le fiamme che lambiscono pian piano la Tana del Lupo sino a devastarla sono il sipario calato anzitempo su una vita troppo breve nell’ottica della normali aspettative ma infinita se calcolata con il tempo effimero del passaggio delle stelle cadenti.
Romana Petri
Figlio del lupo
Mondadori
pagg. 375
€ 19.50
https://www.scriptandbooks.it/2020/05/16/la-notte-turbinosa-di-jack-london-figlio-del-lupo-di-romana-petri-ed-mondadori/
anche su Artcicolo21
https://www.articolo21.org/2020/04/la-notte-turbinosa-di-jack-london-figlio-del-lupo-di-romana-petri-ed-mondadori/