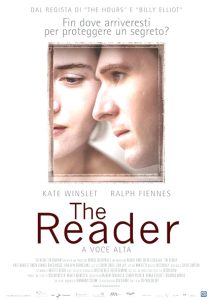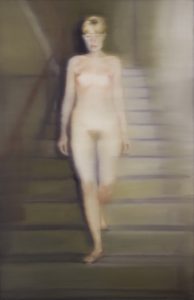Il recupero memoriale dei morti. ‘Pranzi di famiglia’ di Romana Petri, ed. Neri Pozza

L’invito a fare un bagno sulle spiagge dell’Alentejo e l’esortazione a far presto, perché di tempo ne è rimasto poco, mettono in moto il meccanismo dell’impetuoso flashback – che costituisce il romanzo quasi per intero giocato su più piani temporali – di Ovunque io sia, il primo libro della trilogia di Romana Petri.
Il dialogo su una panchina del Prìncipe Real con la richiesta di perpetuare la memoria dei morti è invece il fulcro dal quale si dipana Pranzi di famiglia, il secondo atteso romanzo di ambientazione portoghese, edito da Neri Pozza, che la Petri ha regalato ai suoi lettori. In entrambi i casi si tratta di un sogno, l’unico non luogo in cui possono avvenire gli incontri negati dalla realtà – in questo caso quello di Vasco e della madre Maria do Ceu – l’unico spazio libero in cui si intrecciano desideri che la ragione non permette di esprimere e moniti che hanno il sapore di imperativi categorici, specie se espressi dalla coscienza stranita dallo stupore per l’assenza che la morte si lascia sempre dietro come una scia infetta. Perché se è vero che una madre, ovunque si trovi dopo la morte, continuerà a camminare accanto ai suoi figli, è anche vero che affinché questo avvenga è necessario che i figli ne alimentino il ricordo, ne ricostruiscano la fisionomia, gli atti e il calore, mettendo assieme frammenti, immagini, parole, sensazioni che non possono essersi spenti semplicemente con la morte.
Semplicemente? Sì, semplicemente, perché la morte, sembra volerci suggerire la Petri, non può essere considerata un trapasso definitivo ma un trasferimento in altri mondi nei quali si può permanere solo se agganciati alla vita attraverso il ricordo. E non è necessario scomodare verità ultraterrene per avvalorare questa ipotesi se persino Foscolo aveva detto che “sol chi non lascia eredità d’affetti poca gioia ha dell’urna” e, in questo caso, l’urna non sarebbe un solenne sepolcro all’ombra dei cipressi ma il cuore di quanti hanno conosciuto e amato chi è andato in quell’altrove sconosciuto e misterioso che si chiama morte. Per questo Maria do Ceu, personaggio che i lettori di Ovunque io sia avranno di certo molto amato, consegna al figlio la richiesta pressante di non lasciarsi trasportare dalla deriva del dolore ma di consentirle di abitare quel mondo attraverso il recupero memoriale.
Impresa ardua per Vasco, da sempre afflitto da una strana reticenza al ricordo, che non si avvarrà del recupero attraverso le sensazioni percettive di proustiano sapore, ma ricorrerà ad un indefesso esercizio della memoria, ad una disciplina imposta a se stesso che lo condurrà a rapide illuminazioni, a date dalle quali estrarre grumi da distillare, a stanze in cui far muovere chi vi ha vissuto. Così si costringerà ad annotare su un quadernetto tutto quello che riuscirà a salvare della sua infanzia illuminata e devastata – nel violento ossimoro dettato dalle circostanze – da una madre che si è svuotata di forze e di eventuali felicità per amore dei suoi tre figli: Rita, anzitutto, nata con un volto simile ad un quadro di Picasso, alla quale ha tentato tenacemente di restituire sembianze accettabili sottoponendola a complicatissime operazioni chirurgiche, e i gemelli Vasco e Joana, entrambi bellissimi per uno strano scherzo del destino, lui fragile e irrisolto, costantemente proteso alla ricerca di qualcosa di inafferrabile, lei divorata dal senso di colpa per quella bellezza che si trasforma in supplizio nella sorella deforme.
L’intimità propria dei legami familiari era stata pura e spontanea solo attraverso la mediazione della madre; dalla sua morte cessa di esistere tra i fratelli orfani di luce e di affetto incondizionato e soprattutto di quel collante necessario che era stato voluto e caparbiamente perseguito e imposto da Maria do Ceu anche nella fase terminale della sua malattia. Un ultimo disperato tentativo di lasciare in eredità l’armonia tra i suoi figli era stato compiuto attraverso un viaggio di piacere in Austria, ma dopo pochissimo tempo lo spegnersi della fiammella inesausta del suo amore aveva destinato i figli al silenzio perpetuo o almeno al mantenimento di rapporti incancreniti dalla presenza di un padre sostanzialmente estraneo, Tiago, dedito alla carriera e alla moltiplicazione a tempo indeterminato del successo professionale, del denaro, del pubblico consenso.
Tiago pensa di assolvere al suo compito paterno con i pranzi domenicali, durante i quali riunisce la famiglia. Per quietare la coscienza, si tira dietro lo schizofrenico fratello Humberto – personaggio poeticamente riuscitissimo cui la Petri dona riflessioni da filosofo incompreso – e lo pseudo suocero Manuel Ramalhete – altro personaggio baciato dalla grazia – ma lascia fuori Marta, l’ambiziosa compagna e poi moglie che ha sostituito l’infelice Maria do Ceu con una ventata di giovinezza e di alleggerimento dai problemi e con la capacità di appagare il narcisismo necessario all’uomo come l’aria.
Così la Petri decide di mettere a fuoco la famiglia dos Santos in quei residui commestibili di relazioni fasulle sopravvissute allo sfacelo affettivo, in quei pranzi domenicali nei quali si consuma il rito officiato da Tiago con lunghi monologhi, mentre gusta cibi raffinati, stappa vini pregiati, sciorina i successi ottenuti e commenta i viaggi effettuati e quelli ancora in programma. Non importa se i fedeli di quelle messe profane non gli tributano gli onori sperati, per lui è necessario tenere formalmente in vita l’idea di un nucleo familiare ancora esistente, per lui forma e sostanza possono e devono coesistere.
Lo sguardo dell’autrice è volutamente asettico, perché le emozioni devono sprigionarsi dalla materia narrata e non dal giudizio del narratore che si limita ad esporre fatti ed analizzare sentimenti lasciando cadere qua e là osservazioni di struggente bellezza e verità sui rapporti umani, sulla vita e sulla morte.
La Petri restringe inoltre il suo campo d’indagine, passa dai campi lunghi e medi di Ovunque io sia ai primi piani e ai dettagli (con un’operazione quasi speculare a quella effettuata nei quadri del personaggio chiave della pittrice Luciana Albertini) e, proprio per questa maggiore vicinanza, il racconto si fa luce che illumina angoli bui, coglie tra il non detto lo strazio dei personaggi, addita quel fastello di giorni ancora buoni che avrebbero potuto essere vissuti, quel groviglio di sentimenti autentici con i quali avrebbero potuto lenire un dolore in tutti identico e ugualmente devastante che preferiscono invece dissipare nella rinuncia. Una rinuncia che passa attraverso la rimozione di memorie scomode che potrebbero riplasmare in peggio il passato e che si fortifica nell’illusione che ci saranno altre occasioni per chiarire, altri pranzi domenicali durante i quali tirare fuori rancori sotterranei e tensioni esplosive.
La Petri lascia che la scrittura fluisca limpida anche quando potrebbe intorbidarsi, giunge a scavare laddove mancano le parole, trascina in piccoli gorghi narrativi che promettono tempesta finché il silenzio denso prende corpo in immagini, ricordi, indagini introspettive che aprono squarci su territori accidentati che il lettore può percorrere anche violando il naturale riserbo dei personaggi
L’unica a manifestare la sua cieca rabbia è Rita con i suoi furori esagerati e talvolta pretestuosi, gli altri preferiscono rimuginare malumori e mettere la sordina ai dispiaceri. Vasco e Joana recidono il rapporto esclusivo dei fratelli gemelli per accantonarlo e persino umiliarlo con la rinuncia alla confidenza e alla complicità. A cementare la loro unione era stato in passato quel continuo elemosinare il tempo e l’attenzione materna tutta concentrata sulla sofferenza di Rita, ma mentre la vita di Vasco subirà uno scossone che aprirà nuove prospettive determinando scelte di costruttiva rottura, per Joana sarà l’inizio di una caduta interminabile. La maternità che l’aveva inizialmente ubriacata di gioia, si trasforma presto nella presa d’atto di un fallimento esistenziale che passa attraverso il fallimento coniugale. Il mediocre marito che aveva scelto per autopunirsi della prestanza fisica che arrecava dolore alla sorella, come la madre aveva intuito, la mortifica con il tradimento, ma lei preferisce ingoiare, l’orgoglio le suggerisce di tacere, di non rivelare il cedimento e poi il crollo della vita agiata e promettente che pensava di condurre con lui. La discesa è talmente vertiginosa da spingerla ad accettare l’aiuto economico del padre detestato, andare in analisi e restare vittima di uno di quei transfert difettosi che non portano alla fiducia in chi deve curare le ferite dell’anima ma alla dipendenza ossessiva, alla riesumazione dei torti subiti e alle recriminazioni senz’appello. E, beffa tra le beffe, Joana sarà l’unica, infine, ad accettare la sussistenza della forma, a divenire in questo persino simile al padre, la meno amata da lui e paradossalmente la più vicina.
Nelle giornate incolori di Vasco esplode invece la vitalità contagiosa di una talentuosa pittrice italiana, Luciana Albertini (personaggio appena evocato nel romanzo precedente), un po’ più grande d’età perché il buon Edipo ci mette sempre il naso. Ad accompagnarla c’è il vecchio cane Barabba, fratello letterario di Osac, protagonista de Il mio cane del Klondike, sul quale la Petri lascia come impronta personale la consueta passione per il mondo animale indagato con la stessa delicatezza e la stessa precisione riservate all’agire all’animo degli uomini. La Albertini, medico votato all’arte come l’artista perugina quasi omonima cui il personaggio è ispirato, irrompe con le sue tele dai titoli bizzarri e i suoi colori, con il suo corpo minuto e quasi androgino, con la sua saggezza striata di follia a curare la malinconica sottrazione alla vita di Vasco e soprattutto ad osservare con la lente deformante dell’ironia quella strana famiglia in cui – come lo stesso Vasco riconosce e afferma – sembra che tutti abbiano gli aculei sulla groppa e che si tengano a distanza, capaci di conservare solo il silenzio. Sarà proprio lei a dissacrare la solennità di quei pranzi con una mostra blasfema in cui la famiglia del suo compagno viene svelata nei suoi tratti più grotteschi e in quelle tele riemergeranno con tenerezza anche altri personaggi indelebili di Ovunque io sia come la zia Julieta, dalle gambe sottili come alghe, che aveva vissuto tutta la vita strisciando al suolo e non aveva mai smesso di sorridere. Ma il passato è in agguato, bussa alle porte finché ad aprire sarà proprio l’irascibile Rita, che tirerà fuori dall’oblio quei ricordi ostinatamente negati per riscrivere la mitologia che appartiene sempre ad ogni famiglia. Rita rinuncerà anche ad altri interventi correttivi per mantenere le sembianze del viso che la madre ha conosciuto e amato, l’accettazione di se stessa e della sua deformità è il dono più bello che possa offrirle.
Lisbona e i luoghi cari del Portogallo, altra patria elettiva della Petri, sono presenti con le loro atmosfere e i loro piatti – dal bacalhao alla carne de porco à alentejana — con quei tipi umani un po’ ombrosi in cui la scintilla della gioia si accende raramente, con la saudade, quell’intraducibile disposizione d’animo propria dei lusitani. E’ tangibile l’agio con cui l’autrice si muove su strade conosciute e modalità comunicative perfettamente note, gioca in casa e vincere la partita è fin troppo facile. Nonostante Pranzi di famiglia abbia una totale autonomia narrativa e che non sia indispensabile conoscere anche il precedente Ovunque io sia, il consiglio è quello di leggerli comunque entrambi nel loro ordine naturale, anzitutto perché si guadagna un’altra bellissima storia e poi perché personaggi come Manuel Ramalhete e la moglie Ofelia, genitori “adottivi” di Maria do Ceu e quindi nonni dei tre fratelli, sono troppo preziosi per non conoscerli interamente. Il primo, donnaiolo impenitente, tratteggiato egregiamente nella piena decadenza, è uno dei commensali dei pranzi di famiglia, vi giunge come un pietoso trofeo del passato, con il suo interminabile conteggio dei morti, con il suo pianto teatrale, con la sua falsità ammaliante, con la sua amarissima vecchiaia alla desolata casa di riposo Cruz Vermelha spacciata per privilegio; la seconda è un ricordo intermittente, una presenza incombente nonostante l’assenza, un ritratto geniale dell’Albertini. Appropriarsi del loro travagliato passato e di quello di tanti altri personaggi indimenticabili sarebbe pertanto operazione affascinante.
Pranzi di famiglia è un romanzo sulla capacità di guardarsi dentro, sulla forza del destino, sulla necessità di rompere ciò non può essere aggiustato, sulla fiducia nei cambiamenti necessari e sulla speranza da portarsi appesa al collo come un amuleto. Ed è in fondo un riconoscersi, con il proprio vuoto e i propri fallimenti, con i propri interrogativi destinati a restare senza risposte. E’ ascoltare quei silenzi intorno alle cose finite, sui quali il tempo non ci concederà più di ritornare.
Romana Petri
Pranzi di famiglia
Neri Pozza Editore, 2019
pp.414
http://www.inscenaonlineteam.net/2019/05/06/il-recupero-memoriale-dei-morti-pranzi-di-famiglia-di-romana-petri-ed-neri-pozza/
anche su Articolo21.org
https://www.articolo21.org/2019/05/il-recupero-memoriale-dei-morti-pranzi-di-famiglia-di-romana-petri-ed-neri-pozza/

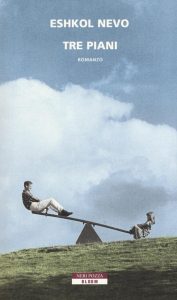
 Acclamato e blandito dalla critica che lo ha definito “un filosofo-scrittore”, Bernhard Schlink ha consegnato ai suoi lettori l’ultimo romanzo Donna sulle scale, edito da Neri Pozza.
Acclamato e blandito dalla critica che lo ha definito “un filosofo-scrittore”, Bernhard Schlink ha consegnato ai suoi lettori l’ultimo romanzo Donna sulle scale, edito da Neri Pozza.